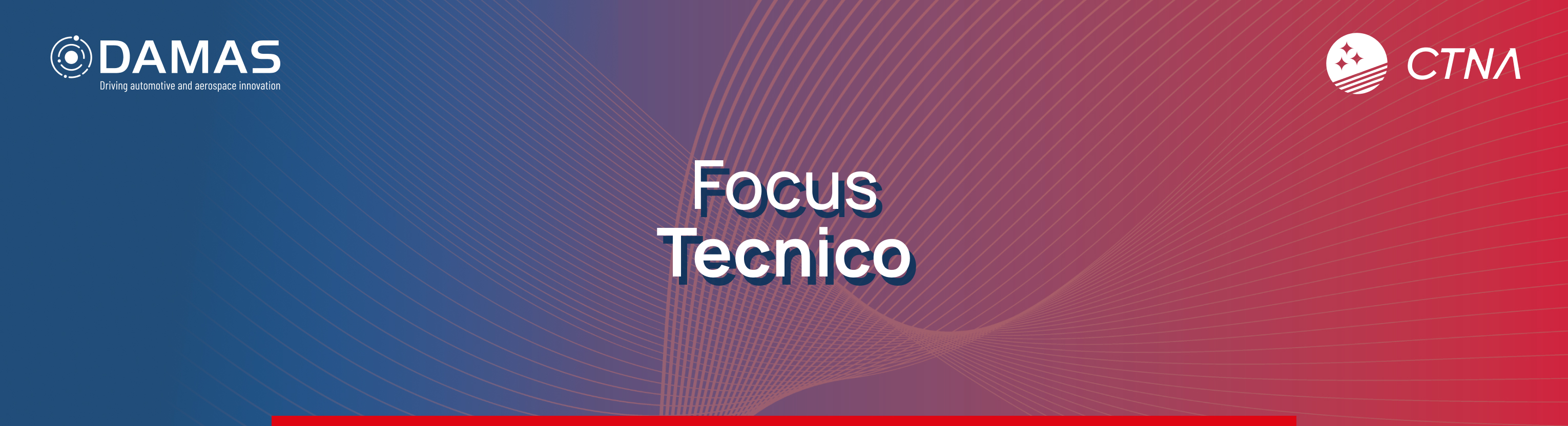On. Andrea Mascaretti: “L’Italia nello spazio: fare sistema per restare protagonisti”
Quali sono, a suo avviso, le prospettive di crescita della Space Economy italiana nei prossimi anni?
La Space Economy, in senso proprio, è quella che in Italia sta prendendo forma e che, in altri Paesi come gli Stati Uniti, è già una realtà consolidata. È la dimensione in cui esiste un’economia dello spazio che funziona autonomamente, con una remunerazione diretta degli investimenti effettuati dalle imprese, indipendentemente dal sostegno pubblico.
Faccio un esempio concreto: Elon Musk fa Space Economy quando investe nei lanciatori rendendoli totalmente riutilizzabili. È un investimento che fa in autonomia — non gliel’ha chiesto la NASA — e che gli consente di abbattere i costi di lancio, effettuare molti più voli e rendere economicamente sostenibile quell’attività.
Ma non solo: grazie a questa strategia ha potuto sviluppare la costellazione satellitare Starlink, con la quale offre servizi privati di connessione. È un privato che lancia i propri satelliti e vende direttamente servizi ai cittadini, anche in Italia: chiunque può acquistare l’antenna di Starlink e avere accesso ai dati anche in aree isolate, dove non c’è copertura dei normali operatori telefonici.
Per fare un altro esempio, la cosiddetta “flottilla” — non entro nel merito politico — che prevedeva un collegamento internet stabile per trasmettere in tempo reale video e interviste H24 in tutto il mondo, ha utilizzato proprio la tecnologia Starlink.
Questo dimostra che, quando la tecnologia offre servizi utili e commercializzabili, la loro diffusione cresce rapidamente. Più aumenta la scala — più satelliti vengono messi in orbita, più si abbassano i costi di lancio — più diventa accessibile a tutti.
È quindi il settore di servizi generati dai dati satellitari ad essere il più promettente?
Oggi il comparto satellitare è al centro di una vera rivoluzione, non solo per la costruzione e il lancio di assetti spaziali, ma soprattutto per i servizi che ne derivano.
Penso, ad esempio, alle cosiddette “zone bianche” o “aree grigie” dove non è conveniente per gli operatori portare cavi o antenne: lì il satellite può garantire connettività e servizi essenziali.
La soluzione più efficace è l’integrazione tra rete terrestre e rete satellitare, che assicura continuità anche in caso di emergenze o calamità naturali.
In queste situazioni, il satellite consente di mantenere comunicazioni vitali, monitorare il territorio in tempo reale e coordinare i soccorsi.
Anche nei piccoli comuni o nelle isole minori la connettività satellitare può fare la differenza, portando didattica a distanza, telemedicina e servizi digitali dove prima non arrivavano.
Si tratta di scenari che fino a pochi anni fa sembravano impossibili.
Quali sono oggi le principali opportunità economiche legate alla Space Economy?
Il vero valore oggi è nella trasformazione dei dati satellitari in servizi concreti: sicurezza, connettività, monitoraggio ambientale, tracciabilità e gestione del territorio.
Non si tratta solo di costruire e lanciare costellazioni, ma di usare i satelliti per migliorare la vita quotidiana e l’efficienza dei servizi pubblici e privati.
Penso, ad esempio, a un catasto digitale aggiornato con immagini satellitari, capace di mappare edifici, superfici e piani, verificare abusi edilizi e supportare la pianificazione urbana.
Oppure alla certificazione delle filiere: sensori e dati satellitari possono tracciare prodotti agricoli e alimentari, garantendo provenienza, condizioni di trasporto e rispetto della catena del freddo.
Con lo stesso principio, le assicurazioni possono verificare danni dovuti a eventi meteo estremi, frane o incendi; e nel settore marittimo i satelliti permettono di monitorare sversamenti e discariche abusive, riducendo i danni ambientali.
Tutto questo genera un’economia nuova, fatta di servizi digitali e soluzioni tecnologiche che coinvolgono università, startup e imprese di ogni dimensione.
L’Italia ha le competenze per essere protagonista, puntando sulla leadership nei servizi più che sulla produzione di massa, e valorizzando il capitale umano e l’innovazione diffusa del Paese.
Su quali attività sta lavorando attualmente l’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy?
L’Intergruppo parlamentare per la Space Economy non deve scegliere “priorità settoriali”: quelle le indicano PA, imprese e cittadini.
Il nostro compito è facilitare l’accesso, rimuovere ostacoli e creare un terreno di crescita per le imprese italiane—grandi, medie e piccole.
Fondamentale è la collaborazione pubblico-privata. Solo attraverso un dialogo costante tra istituzioni, ricerca e industria possiamo garantire un ecosistema capace di trasformare l’innovazione tecnologica in valore economico e sociale.
L’obiettivo dell’Intergruppo è proprio quello di facilitare questo scambio, promuovendo norme e strumenti che rendano più semplice l’accesso al mercato per le imprese italiane e favoriscano la nascita di nuove partnership.
Lei è stato relatore della prima legge sullo spazio italiana. Quali sono secondo lei i suoi elementi chiave e gli elementi di miglioramento, se ci sono?
La legge italiana sullo spazio aiuta questo percorso: crea il quadro di regole senza il quale non c’è mercato.
Il mercato della Space Economy è decollato negli Stati Uniti; oggi ci sono più operatori: Starlink ha aperto la strada, ma non c’è monopolio—arrivano Amazon, Kuiper e altri.
Kuiper punta a oltre 3.000 satelliti, sufficienti per offrire servizi su gran parte del pianeta.
C’è poi un mercato nuovo legato al ciclo di vita: un satellite dura 5–8 anni (a volte meno).
Con costellazioni da decine di migliaia di satelliti, la sostituzione è continua: quando arrivi a 7.000 operativi, i primi vanno già rimpiazzati.
Nasce anche il mercato del de-orbiting e del servicing: raccogliere satelliti a fine vita, recuperarne materiali, rifornirli, sostituire pannelli e payload, ripararli in orbita, allungandone la vita a 10–15–20 anni.
Con tanti satelliti, conviene creare “factory” e laboratori in orbita per rigenerare invece di rilanciare sempre materia prima dalla Terra.
È un settore che non esisteva, ma diventa economicamente sostenibile con numeri così grandi.
A livello europeo si parla di uno “Space Act UE”: l’Italia farà da modello con la sua legge quali ricadute può avere per il nostro Paese?
Sarebbe sbagliato se l’Europa andasse in un’altra direzione.
La nostra legge è tra le più moderne e prevede davvero l’economia commerciale dello spazio.
L’Europa dovrebbe armonizzare, non penalizzare chi ha già normato.
L’auspicio è evitare doppia burocrazia: fissare un’asticella comune e riconoscere i modelli nazionali adeguati, a partire da quello italiano.
È positivo che la relatrice in Parlamento europeo sia italiana, l’on. Elena Donazzan: anche grazie agli Stati Generali dello scorso anno si è rafforzata la posizione italiana in Europa.
Ci avviciniamo agli Stati Generali della Space Economy 2025. Quali sono i principali obiettivi dell’evento?
È la seconda edizione. Quella dello scorso anno ci ha dato grandissime soddisfazioni: era la prima, quindi abbiamo dovuto sperimentare questo modello e questa idea di fondo, cioè riunire tutto l’ecosistema che riguarda la Space Economy italiana.
Gli Stati Generali 2025 crescono: tre sedi e tre giornate.
Si parte il 27 ottobre a Roma, alla Farnesina, dedicando la giornata alla diplomazia dello spazio (accordi e cornici legali per partecipare ai programmi internazionali e per l’export tecnologico).
Il 30 ottobre a Torino si parlerà di intelligenza artificiale applicata allo spazio, unendo due frontiere che già viviamo.
Il 31 ottobre a Milano, all’Hangar Bicocca, otto sezioni tematiche al mattino e la plenaria al pomeriggio, con due novità: una sessione dedicata specificamente alla nuova legge italiana (decreti attuativi) e una alle startup e microimprese ad alta innovazione.
Resta anche la sessione sullo Space Act europeo.
L’Italia ha mille eccellenze; quando fa sistema, è imbattibile.
Il compito dell’Intergruppo e degli Stati Generali è facilitare connessioni tra Parlamento, Governo, imprese, ricerca, finanza—così che l’economia dello spazio diventi volano per tutto il Paese, mantenendo il nostro vantaggio competitivo e guidando—da protagonisti—sviluppo e regole in Europa e nel mondo.
di Roberta Busatto